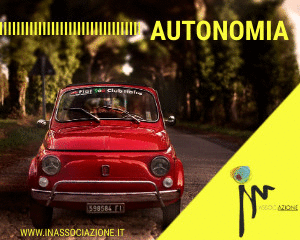Un divorzio tardivo di Abraham Ben Yehoshua. “Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
“Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
Iniziamo una nuova rubrica di recensioni, a cura dello scrittore e traduttore Maurizio Grasso.
Non sono sempre necessariamente recensioni di libri appena usciti, ma di “buoni libri”.
Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere Un divorzio tardivo di Abraham Ben Yehoshua.
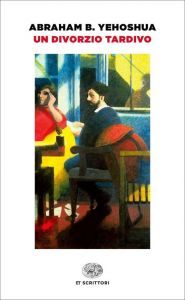 Il 14 giugno, poco più di un mese fa, ci ha lasciato Abraham Yehoshua, uno dei maggiori scrittori viventi. Mi sembra giusto inaugurare questa rubrica dedicata ai libri con un suo romanzo.
Il 14 giugno, poco più di un mese fa, ci ha lasciato Abraham Yehoshua, uno dei maggiori scrittori viventi. Mi sembra giusto inaugurare questa rubrica dedicata ai libri con un suo romanzo.
Di Un divorzio tardivo si potrebbe dire che è un’opera originale e ingegnosa; ma è soprattutto un romanzo bellissimo, intenso e coinvolgente, pieno delle emozioni e riflessioni dei suoi personaggi e dove non mancano i colpi di scena.
La famiglia Kaminka è una metafora della società israeliana: aspirazioni contrastanti la dilaniano, ma una forza ancora maggiore impedisce che vada in pezzi.
Per i Kaminka è l’affetto reciproco pur nella dolorosa incapacità di comprendersi; per Israele è la necessità vitale di tenersi abbarbicato attorno a valori che, in fondo, si sanno non pienamente condivisi da tutti: il sangue, la storia, le tradizioni degli avi, la religione.
La costruzione di questo romanzo è corale: una sola storia che, osservata dentro un caleidoscopio, si scinde in tante vicende diverse quanti sono i suoi testimoni. Il divorzio “tardivo” è mostrato in ogni capitolo dal punto di vista di un diverso personaggio di una famiglia sparsa tra Haifa, Tel Aviv, Gerusalemme e Minneapolis.
Pur essendo un testo in gran parte costruito sul flusso di coscienza e sulla parziale assenza di punteggiatura, gli occhi restano calamitati sulla pagina.
Yehoshua ha il dono del narratore di razza e non ha il vezzo della sperimentazione. Tutto è asservito a un intento affabulatorio.
In Un divorzio tardivo, ogni capitolo prende una giornata della settimana che precede la Pasqua ebraica. In questa settimana israeliana sono i personaggi che si alternano alla “parola”, a battere questo tempo compresso, dove accadono innumerevoli cose: il tempo di un divorzio tardivo.
Si inizia col punto di vista di Gadi, un bambino di sette anni che ha atteso per settimane la venuta di un nonno dall’America. Eppure, quando arriva, nonno Yehuda non trova mai tempo per lui, non gli ha portato neanche un regalo, dorme sempre di giorno per via del jet lag. Il racconto tradisce il rapporto impari tra i suoi genitori, con sua madre Yael (figlia dei divorziandi) succube della personalità tirannica del marito.
Che sarebbe Israel, il padre di Gadi, io narrante del lunedì. Da lui il bambino ha preso la tendenza a ingrassare e un certo umorismo, non la loquela disseminata di battute, che gli altri percepiscono il più delle volte come gaffe.
Israel Kedmi fa l’avvocato, questo divorzio dei suoceri è una grana che, col senno del poi, si sarebbe risparmiato, ma come sottrarsi ormai?
La suocera Na’omi è ricoverata in manicomio e lui, troppo sicuro di sé, non riesce a farle firmare l’accordo di separazione. È un giullare incompreso. Resta un estraneo per tutti i Kaminka.
Terzo capitolo, martedì. È Dina l’io narrante, la nuora della coppia di anziani divorzianti, moglie del figlio minore Assa. Dina ha velleità letterarie. Va all’appuntamento con questo suocero che non ha mai conosciuto, venuto a Gerusalemme apposta per vederli. L’incontro la sorprende e la turba. Yehuda Kaminka è un vero personaggio, proprio quelli che Dina cerca. Yehuda potrebbe essere il protagonista di un intero romanzo. Yehuda si lascia sfuggire, al primo incontro con quella che in fondo è un’estranea, un segreto: è scappato in America perché la moglie ha tentato di ucciderlo. Per questo è ricoverata in un manicomio. Ha fretta di concludere il divorzio perché Connie, la sua nuova compagna americana, è incinta.
Sorvoliamo sul mercoledì, quando la parola tocca ad Assa, il figlio minore, l’intellettuale. Il giovedì è del figlio trentenne Zwi, ma Yehoshua inventa un espediente narrativo per non fargli dire una sola parola. Un dialogo dimezzato. Ci sono solo le parole di uno dei due, il suo “amico” Refael, un dirigente di banca sefardita di mezza età con cui Zwi ha una relazione, piombato in casa in piena notte, mentre il padre, ospite del figlio, dorme. Yehuda si sveglierà, troverà quest’uomo, capirà tutto.
Passiamo oltre il venerdì, dedicato a Zwi a al suo psicanalista. E il sabato? C’è un punto interrogativo anche nel titolo del capitolo. È Yael, la figlia maggiore, che parla. Sono passati tre anni, è accaduto qualcosa di tragicamente inatteso.
Gli ultimi due giorni-capitoli danno voce ai due vecchi coniugi: come potrebbe essere altrimenti?
Viene il Seder di Pesach, e stavolta tocca alla appena divorziata Na’omi raccontare. Lo passerà in manicomio. È il capitolo più intenso e drammatico del libro, benché sia il più breve. Un triste, squallido Seder in cui lei ricorda la turbolenta cerimonia del divorzio avvenuta poche ore prima. Prima di vedere Yehuda per l’ultima volta chiede all’ormai ex marito di mostrarle la famosa ferita che lei gli ha procurato. «Sono l’unica persona che non ha mai visto quella cicatrice che fai vedere a tutti». E a vederla è lei, non l’altra che è in lei. Uno sentimento misto di libertà e di nostalgia la prende. «Mai più lo sentirò rivolgermi la parola, ho eliminato quella sua parlata forte che mi ha perforato la vita».
È arrivato l’ultimo giorno di Yehuda Kaminka prima di ripartire. Doveva essere un bel giorno, finisce in una catastrofe. Non posso rivelare il finale.
Nello studio dei caratteri di Yehoshua fanno capolino due pregiudizi interni alla società israeliana mai sradicati. Il primo è quello degli ashkenaziti colti verso i sefarditi, in particolare verso quelli di origine magrebina, guardati come buoni selvaggi da alfabetizzare daccapo su tutta la tradizione ebraica. Il secondo è quello dei laici verso gli ortodossi, più velato, paternalistico, l’atto di superiorità della mente evoluta che deve affettare tolleranza anche verso chi non comprende. C’è soprattutto l’interrogarsi sul senso di questa nuova Patria — troppo pochi trent’anni a casa dopo due millenni in esilio — e proprio Yehuda, sola coscienza critica della famiglia, rimasto sospeso tra una seconda Alià (che doveva durare nove giorni) e una Diaspora scelta senza troppa convinzione, ne è il simbolo inquieto e tormentato.
Abraham Ben Yehoshua è stato uno dei maggiori scrittori israeliani, ingiustamente meno letto in Italia di quanto lo siano, per esempio, Amos Oz o David Grossman. In patria è considerato lui il caposcuola, e questo libro, ne sono convinto, una volta letto farà venire la voglia di leggere anche gli altri.