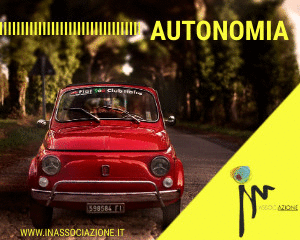Recensioni – “Il suono della montagna”, un capolavoro della letteratura nipponica
“Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
Livorno 28 settembre 2022 – “Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
Rubrica di recensioni, a cura dello scrittore e traduttore Maurizio Grasso.
Non sono sempre necessariamente recensioni di libri appena usciti, ma di “buoni libri”.
Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Il suono della montagna”, un capolavoro della letteratura nipponica
“L’impero dei simboli e dei silenzi”
Chapeau a questo capolavoro della letteratura nipponica. Benché come ogni libro sia fatto di parole, Il suono della montagna di Yasunari Kawabata è un romanzo avvolto in un velo di silenzi. Non solo per ciò che i personaggi tacciono, limitandosi a pensarlo, anche nei dialoghi, che sembrano sussurri. Perfino il vissuto che si racconta pare fatto di niente. Un girasole reciso, il rombo che annuncia un tifone, il frullare d’ali di una cincia, un sogno che in vecchiaia è un sussulto di gioventù. E, appunto, il “suono della montagna”, che nessuno sa cosa sia e dove abbia origine. Eppure ogni tanto qualcuno lo avverte e si chiede se premonisca qualcosa.
La natura (non è una novità nella letteratura giapponese) non è un semplice decoro, è protagonista.
Ogni albero, ogni fiore, ogni uccello costituiscono un simbolo riconducibile a una stagione, a un momento di passaggio o a uno stato d’animo. Conoscenze botaniche diffuse sono la regola, non l’eccezione. Una serpe è considerata dalla famiglia lo “spirito padrone” della casa, in cui abita da prima di essa, e come tale rispettata.
Il suono della montagna è solo apparentemente la cronaca del passaggio di testimone tra generazioni di una stessa famiglia. In realtà è la storia di un grande Paese che, come un serpente, sta facendo una muta di pelle inaspettatamente rapida. L’autore mette a fuoco i problemi del suo popolo; posa la lente sulla decadenza, non tanto della famiglia Ogata in particolare, quanto dell’istituzione familiare come secolare cellula fondante della società nipponica. Quando nel 1968, ormai settantenne, fu insignito del Nobel, Kawabata elegantemente dichiarò: «Più che a me, è stato dato alla letteratura giapponese». Era il primo orientale a ricevere l’ambito riconoscimento.
Il dramma di un uomo scavalcato dal Tempo
Siamo nel secondo Dopoguerra, in un Giappone ancora ferito, benché soffra in silenzio e con la dignità che gli è propria. Kawabata non fa alcun cenno a Hiroshima e Nakasaki, al discorso tragico dell’Imperatore dopo la resa, all’occupazione americana che ancora perdura. Ma la guerra incombe col suo ricordo, la guerra che ha fatto un’ecatombe di ragazzi e ha prodotto una moltitudine di giovani vedove. Un Paese che pareva colpito a morte nei suoi valori più preziosi, sorprendentemente, si sta rialzando e sta tornando alla normalità. Una “nuova” normalità, non quella di una volta.
È questo a provocare un malessere vago e oscuro nel protagonista. Il sessantenne Shingo Ogata soffre di amnesie sempre più frequenti e serie, ma non è questo il suo principale cruccio.
Si sente investito del ruolo di capofamiglia secondo la tradizione che ha ereditato da suo padre; tuttavia si rende conto che la realtà gli sfugge di mano, non solo perché invecchia. Suo figlio Shūichi vive in casa dei genitori con la giovane moglie Kikuko, estremamente servizievole soprattutto verso il suocero. Però Shūichi la trascura deliberatamente, rientrando tardi la sera e frequentando un’amante. La figlia maggiore, Fusako, ha due bambine. Il suo è un matrimonio infelice e ora grava sulla famiglia d’origine il rischio di un suo problematico ritorno a casa.
Tutto questo crea grandi inquietudini e un senso di inadeguatezza nel vecchio capofamiglia. Vorrebbe correggere il figlio, che non merita una moglie dolce come Kikuko: non sa da dove cominciare. Per giunta viene biasimato dalla moglie Yasuko. Per lei la sua eccessiva benevolenza verso la nuora la tiene in ostaggio e le impedisce di ribellarsi ai tradimenti del marito. Per quanto Shingo cerchi rassicurazioni nel presente, la discontinuità dispetto al passato lo incalza e nulla può fare il vecchio per contrastarla. La sua irresolutezza e la sua impotenza avanzano inesorabili con le pagine. Lo riducono a un essere contemplativo, capace di empatia ma non di decisioni. Si rimprovera aspramente di non essere riuscito a procurare felicità a nessuno e pensa che ormai sia troppo tardi.
Il mondo cambia troppo velocemente attorno al vecchio Shingo, che lo percepisce ma non sa prenderne le misure; si rifugia allora nell’interpretazione dei suoi sogni, talora belli talaltra angosciosi.
La vita è diventata per lui un assedio che gli fa desiderare la morte. Le amnesie di Shingo si possono leggere come un’allegoria dell’oblio in cui va cadendo il suo mondo, rimpiazzato da un altro. Quello dei figli, con rapporti coniugali problematici cui sembrano rassegnati, con una mentalità e una condotta etica inconcepibili per il padre.
Il legame tra suocero e nuora si va sempre più configurando come un rapporto paterno-filiale, non soltanto perché lei per rispetto lo chiama papà. Un giorno viene a sapere da suo figlio che Kikuko ha abortito volontariamente, perché «si sentiva sporca a rimanere incinta adesso». Sporca del tradimento di Shūichi. Shingo trasforma allora l’indulgenza in rabbia e accusa apertamente il figlio di averla uccisa per metà.
Che cosa rappresenta per quest’uomo anziano questo fiore di loto sempre in boccio, pallido, perfetto, che non conosce orgoglio? Forse l’ideale di figlia che avrebbe desiderato e che Fusako non rappresenta minimamente. Forse un’idea ancestrale di donna che la modernità ha spazzato via dal suo Paese. Eppure, malgrado il suo disagio e il suo smarrimento, è Shingo la sola testa pensante di questo microcosmo familiare. È la sua mente a proiettarsi oltre il mero accadere dei fatti. A cercare di divinare dai segni la sorte delle persone che gli sono care. Shingo Ogata resterà per il lettore un personaggio indimenticabile, che solo un grande scrittore poteva concepire.
Una prosa musicale
Come sempre quando si legge un autore del Sol Levante, bisogna entrare nella discreta musicalità della sua prosa. In quella di Yasunari Kawabata si respira una quiete olimpica e drammatica al tempo stesso, come quella del teatro Nō. Anche quando ci sono discussioni accese, è difficile immaginare che qualcuno osi alzare la voce. Le regole ataviche dell’onore e della dignità non bastano però a frenare lo sfaldamento di questo sodalizio fondato sul sangue. Si coglie l’aspra, per quanto indiretta critica alla società post-moderna. Anziché trarre preziosi consigli dalla generazione degli anziani e fare tesoro delle loro esperienze, essa si limita a centrifugarli ai margini della vita. Forse la società giapponese è stata l’ultima tra quelle avanzate a compiere questo sconsiderato sacrificio.
Sia il racconto, sia i dialoghi de Il suono della montagna sono ovattati, permeati di impalpabile delicatezza. Ciò li rende, anche a causa della loro levigata sintassi, della linearità di frasi prive di subordinate, carichi di non detto. Sentimenti e pensieri dei personaggi sono altrettanto profondi di quelli che ci sono familiari in un autore occidentale, da cui ci attendiamo sempre un’espressività complessa.
Il suono della montagna
ci parla soprattutto attraverso gli spazi bianchi tra le parole. Siamo testimoni della declinazione di un’altra metafisica, di una diversa sapienza. Il romanzo di Kawabata apre, attraverso una silenziosa porta scorrevole, un varco discreto verso una cultura che non ci sarà mai abbastanza familiare. Possiamo restarne affascinati, ma difficilmente la comprenderemo nel profondo finché non vivremo immersi nel mondo che essa esprime e simboleggia.