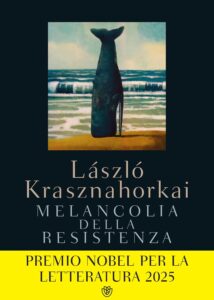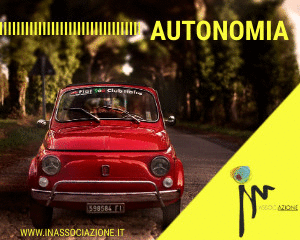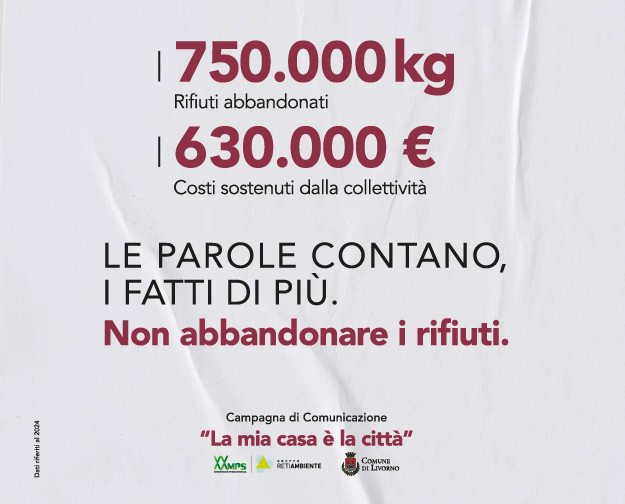Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Melancolia della resistenza” del fresco premio Nobel per la letteratura László Krasznahorkai
10 ottobre 2025 Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Melancolia della resistenza” del fresco premio Nobel per la letteratura László Krasznahorkai
“Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
Rubrica di recensioni, a cura dello scrittore e traduttore Maurizio Grasso.
Non sono sempre necessariamente recensioni di libri appena usciti, ma di “buoni libri”.
Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Melancolia della resistenza” di László Krasznahorkai
Il fresco premio Nobel per la letteratura László Krasznahorkai era uno dei nomi della rosa che girava da anni. Un autore non facile, ultramoderno e antichissimo al tempo stesso.
Melancolia della resistenza, secondo romanzo pubblicato dallo scrittore ungherese, appartiene alla sua “prima maniera”, quella dell’assidua collaborazione col visionario regista Béla Tarr.
Confesso che, ogni volta che ho affrontato questo autore, non so mai cosa aspettarmi dalla lettura — salvo che non sarà una passeggiata. Nell’arco di tre decenni la sua scrittura si è spostata da atmosfere drammaticamente estraniate e simboliche (come in questo libro) a un atteggiamento sofista, a una raffinata cerebralità che esplora il regno dei miti e delle corrispondenze.
Una signora borghese di mezz’età se ne torna a casa trafelata dopo un viaggio in treno che per lei è stato un vero inferno, tra un tentativo di violenza sessuale e una galleria di brutti ceffi avvinazzati che turbavano tutti i suoi delicati sensi. Valuska, il figlio di costei, che la madre ha scacciato di casa per ostinata abulia e che tutti considerano “lo scemo del villaggio”, invita chiunque a guardare il cielo, poiché lì splendono tutte le verità. Una moglie scacciata dal marito si vendica lavandogli (letteralmente) i panni sporchi in pubblico e mettendosi con un capitano di polizia sempre ubriaco. Questo marito, ex direttore di conservatorio, d’un tratto abbandona la vita sociale e matura la convinzione che tutta la storia della musica fondata sul temperamento equabile sia una falsificazione dell’armonia naturale come teorizzata dal peripatetico Aristosseno nel IV sec. A.C.; decide allora di accordare il suo Steinway secondo il trattato del filosofo greco, ma il Bach che ne viene fuori è inascoltabile e lo getta nello sconforto. Un circo “abborracciato” arriva in città attirando tutti con l’esca della “balena più grande del mondo”, ovviamente non viva ma imbalsamata, o impagliata o chissà cosa. Negli stessi giorni bande di teppisti eterodirette da un misterioso figuro che si fa chiamare “il Principe” si scatenano per la città seminandovi concitazione, panico e devastazione, finché la presunta rivoluzione non sarà stroncata dall’intervento dell’esercito al comando di un colonnello, che impone alla città lo stato d’assedio e instaura la corte marziale.
Melancolia della resistenza è un’affabulazione “a modulo continuo” (solo 13 “a capo” in 352 pagine!). Il suo oggetto si sposta insieme al lettore e in fondo è soltanto un pretesto, un casus belli narrativo. Questa è l’impressione che si trae dalle prime avventure. Senonché, come un quadro puntinista osservato da pochi centimetri e da cui poi ci si allontani sempre più, essa è provvisoria e tutto sommato fallace. Tutti questi personaggi surreali sono affaccendati in imprese degne di miglior causa, l’autore ne asseconda con benevola partecipazione gli sforzi immani per conseguire obiettivi senza né capo né coda, ne giustifica la sostanziale alienazione ricamando periodi di decine di pagine attorno a corvè incomprensibili se non le si osserva col metro dell’allegoria e di un umorismo tragico su una questione ontologica (questa sì seria), che trova una sua sintesi in una frase del testo: «la lotta tra ciò che resiste e ciò che tenta di sconfiggere la resistenza».
L’allegoria di Krasznahorkai è che la vita non è che un’eroica, inutile resistenza alla realtà ineludibile dell’impermanenza e dell’insignificanza, e questa resistenza non può che apparire melanconica, nel senso psichiatrico di un’alterazione non transitoria dell’umore, ciò che per Giacomo Leopardi si è chiamato “pessimismo cosmico”. «Siamo protagonisti di un fallimento», fa dire l’autore al signor Eszter, il velleitario musicologo. «Abbiamo fallito con le azioni, i pensieri, l’immaginazione, e persino nei nostri pietosi sforzi di capire il perché del nostro fallimento».
Questa sentenza dal sapore sartriano, inglobando in sé l’intera esperienza e conoscenza umane, coinvolge nella sua generalizzazione il caso particolare del Paese in cui lo scrittore vive, dove questa insignificanza assumeva da tempo (ma ancora per poco) l’aspetto di una cesura tra desiderio di emancipazione e regole etero-imposte, insomma tra Vita e Legge? Ci se ne convince quando ci si imbatte in un’altra frase-chiave: «tutte le idee dominanti, le fissazioni, i giudizi che pretendono di chiudere il mondo entro i confini che loro hanno deciso, distruggono la vita, l’inqualificabile bellezza del meccanismo vivente delle “relazioni reali”». L’allusione ai Paesi del patto di Varsavia è evidente.
László Krasznahorkai è stato e resta una monade nel panorama letterario contemporaneo, sfuggendo a qualsivoglia etichettatura. Per me è figlio di quel mondo alimentato di straniante surrealtà, di distopia e di larvato umorismo che ha covato per decenni nella letteratura mitteleuropea novecentesca, da Kafka e Čapek fino a Hrabal e, non per lo stile ma per certi aspetti pessimisti del pensiero, a Kundera. Sotto il profilo stilistico e per la sua poetica è anni luce lontano dai principali romanzieri prodotti dalla sua terra: Sandor Marai, Magda Szabó, Imre Kertesz.
Krasznahorkai ha iniziato a scrivere sotto il governo di György Lázár, prono a Mosca, e continua a farlo da anni sotto quello sovranista di Victor Orbán. Una sorta di Nemesi per i magiari. In apparenza il contesto sociale ha scarsa influenza sulla sua ispirazione. Nel romanzo non c’è il minimo cenno alla natura del regime in vigore all’epoca in Ungheria. Non mi risulta si sia mai occupato “esplicitamente” di politica nei suoi romanzi (non è neanche quel “genere” di scrittore), ma ne ha parlato sotto traccia, come si è intuito, usando simboli e allegorie che io, umile lettore, credo di cogliere e che uno studioso di questo autore saprà ben argomentare. Certo, leggere nel grande cetaceo imbalsamato di questo romanzo il blocco sovietico ormai pronto, in quegli anni Ottanta, a implodere su se stesso è una chiave interpretativa fin troppo banale. Del resto, nello stesso 1989 in cui Krasznahorkai pubblica Melancolia della resistenza saltano i primi 345 chilometri della “cortina di ferro”, ossia il confine tra Austria e Ungheria, unite per secoli sotto gli Asburgo.
Krasznahorkai non appartiene al mio Pantheon. Per uno come lui non c’è spazio tra le mie idee archetipiche di scrittore. Ne ammiro la ricchezza del linguaggio, l’ardita architettura delle strutture narrative (in particolare nelle opere di questo secolo) ma la sua “grandezza” mi lascia un po’ freddo, mi appare troppo appartata, inessenziale nel percorso del romanzo contemporaneo. Ma non è questa l’opinione dell’Accademia di Svezia.