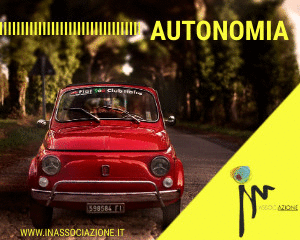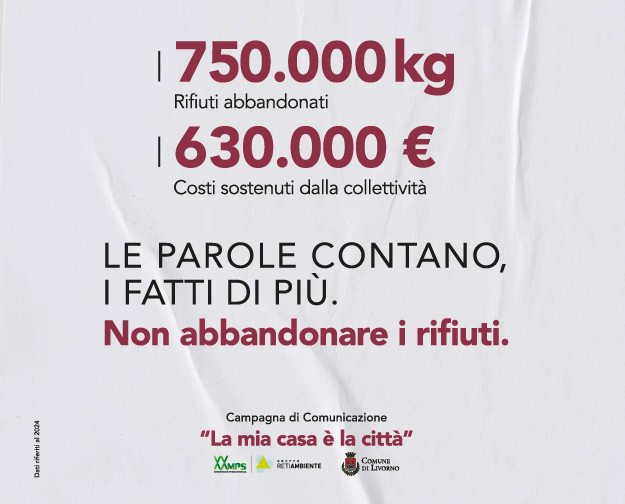Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “La tribù degli alberi” di Stefano Mancuso
Livorno 24 ottobre 2025 Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “La tribù degli alberi” di Stefano Mancuso
“Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
Rubrica di recensioni, a cura dello scrittore e traduttore Maurizio Grasso.
Non sono sempre necessariamente recensioni di libri appena usciti, ma di “buoni libri”.
Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “La tribù degli alberi” di Stefano Mancuso
Con la sua attività di studioso, di saggista e di efficace divulgatore, il neurobiologo Stefano Mancuso ci ha offerto una nuova visione sul mondo delle piante e in particolare su quel sistema complesso che è il bosco. È stata provata la capacità di cooperazione solidale degli alberi attraverso l’apparato radicale, e altresì una forma di intelligenza attribuita di solito a creature dotate di cervello ma mai ai vegetali, da sempre considerati privi di un sistema nervoso.
Eppure una quantità di studi scientifici finalizzati soprattutto nel nostro secolo ha dimostrato che, se all’intelligenza si dà l’accezione di problem solving, allora le piante hanno un’intelligenza collaborativa e diffusa al cui confronto perfino noi Sapiens sembriamo, a giudicare almeno dai risultati, creature primitive.
Al di là delle scoperte scientifiche sulla complessità occulta del mondo vegetale, il messaggio della neurobiologia ha soprattutto un bersaglio politico: le piante si nutrono di CO2 e sono una risposta naturale, la più rapida per la riduzione dei gas serra che stanno provocando il riscaldamento globale e il conseguente cambiamento climatico. Parafrasando una frase attribuita a Dostoevskij, gli alberi salveranno il mondo, ma bisogna piantarne a milioni, a miliardi, e in fretta.
La versione degli alberi è un romanzo. Una sorta di fiaba allegorica, vagamente ispirata a La fattoria degli animali di George Orwell, il quale a sua volta aveva attinto alla tradizione favolistica. Qui i personaggi sono alberi, la forma più grande ed evoluta del mondo vegetale. Il titolo è eloquente: per avere una “versione” degli alberi, è necessario farli parlare. Gli alberi di Mancuso non si limitano a parlare: si muovono sulle proprie radici, viaggiano, filosofeggiano. Gli scienziati alla Mancuso devono essersi stancati di fare da oracoli del mondo vegetale, di farlo parlare per procura. Così alcuni di loro scrivono romanzi. Storie che mescolano la poesia, la sensibilità ecologica e la fiducia, tipica della scienza, che la Natura ci suggerisca sempre le soluzioni ai problemi che il cosiddetto Antropocene le ha creato: basta ascoltarla.
La versione degli alberi ci riporta a Edrevia, al centro anche del precedente romanzo di Mancuso, La tribù degli alberi (2022). L’affabulazione unisce generi letterari tra loro distanti, come la fiaba, il racconto di avventura o fantasy e la chanson de geste. L’affabulazione rende un testo come La versione degli alberi assai più affine a Cappuccetto rosso, a I viaggi di Gulliver e a Il nome della rosa di quanto non lo sia al romanzo realista, in cui di norma il fine pedagogico è assente.
La forma del romanzo consente a Mancuso di raggiungere due scopi. Il primo è una divulgazione affrancata dal linguaggio tecnico, il secondo è la facoltà di sospingere le teorie sull’intelligenza delle piante oltre i limiti attuali delle neuroscienze, per le quali ogni ipotesi deve essere suffragata da prove sperimentali onde essere accolta dalla comunità scientifica, e talvolta anche tali prove sono messe in discussione o accettate con riserva. Insomma, lo scienziato Mancuso ha le mani legate, mentre il romanziere Mancuso può scrivere di tutto, e le critiche che può ricevere sono tutt’al più sulla qualità della sua scrittura e della sua comunicazione letteraria.
Il tema al centro de La versione degli alberi è la presa di coscienza di alcuni abitanti di Edrevia che qualcosa di oscuro minaccia l’equilibrio millenario del loro mondo: insomma, non sono più artefici del loro futuro come un tempo. Laurin, Lisetta e Pino sono i protagonisti della storia e anche le figure più illuminate e sensibili. L’autore concede loro la fantasiosa licenza poetica di viaggiare. Ma è proprio vero che gli alberi non viaggiano? E come avrebbero colonizzato il pianeta? Certo, non camminano sulle loro radici, hanno trovato un sistema più geniale di chi usa zampe o ali: un seme e la collaborazione inconsapevole di un animale o del vento. il nomadismo dell’intera specie, non di un individuo o di un branco.
Viaggiando, Laurin, Lisetta e Pino scoprono che fuori di Edrevia degli “esseri dannosi”, i Nidhoggr (chi se non noi umani?) stanno seriamente compromettendo l’avvenire della comunità arborea. Perché distruggono ciò da cui dipende anche la loro vita? Si chiedono esterrefatti a Edrevia. «Il nostro futuro dipendeva in gran parte dalle incomprensibili abitudini e dalle oscure azioni di chi stava fuori. Non ci conoscevano, non avevano idea che potesse esistere una comunità felice come la nostra». Come in un manga educativo, come in un film per ragazzi alla E.T., anche qui ci sono degli eroi che si attivano per salvare il mondo: il mondo delle piante.
La tradizione cooperativa del mondo di Edrevia è anche una metafora delle comunità scientifiche dove tutto, in un modo o nell’altro, è condivisione. È la regola aurea degli scienziati come pare essere, per Mancuso e altri neurobiologi come lui, per le piante. «Siamo qui poiché non è neanche concepibile che in Edrevia alcune informazioni siano conosciute soltanto da qualcuno», dice l’imponente albero Cronaca aprendo l’assemblea della comunità.
La tradizione favolistica non scarseggia certo di testi dove gli alberi sono umanizzati, acquisiscono una personalità. Anche Hans Christian Andersen si è cimentato nel filone. Tuttavia, leggendo questo romanzo, è impossibile non andare col pensiero a Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati. Se lo scrittore bellunese avvolge il bosco in un alone magico, si concentra sulla sacralità della natura, sull’inviolabilità dei suoi segreti, senza neanche sfiorare il tema escatologico delle sorti del pianeta, non c’è dubbio che Mancuso, attraverso la personificazione degli alberi, abbia contratto un (inconsapevole?) debito verso il romanzo di Buzzati.
La versione degli alberi è un libro che sembra scritto per l’infanzia e in realtà si rivolge soprattutto alla popolazione adulta, che può meglio coglierne la natura di apologo morale sulla deriva apocalittica del nostro pianeta. La sua lettura non fa gridare al miracolo letterario, ma non era certo questo lo scopo del volume. Dopo, sempre che non si sia già sviluppata tale sensibilità, si guarderanno gli alberi con altro occhio, con un rispetto e un’empatia che di solito si riservano alla “vita semovente”: l’umanità alle prese con le sue difficoltà o sventure, la fauna selvatica che senza colpe condivide l’incerto destino che le stiamo riservando.