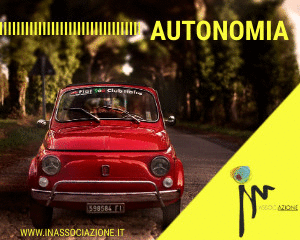Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere L’Agnese va a morire di Renata Viganò
Livorno 25 aprile 2025 – “Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
Rubrica di recensioni, a cura dello scrittore e traduttore Maurizio Grasso.
Non sono sempre necessariamente recensioni di libri appena usciti, ma di “buoni libri”.
Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere L’Agnese va a morire di Renata Viganò
L’Agnese va a morire di Renata Viganò è il capolavoro della letteratura sulla Resistenza. È un libro che, pur parlando di cose accadute ottant’anni fa, fa continuamente ribollire il sangue, a maggior ragione se si pensa alle reiterate amnesie storiche dei politici di oggi. Un libro che sembra più vero del vero, non solo perché vere sono le vicende che vi sono raccontate (per quanto manipolate nei nomi di persone e località), ma perché lo sono doppiamente, grazie alla meravigliosa arte del romanzo che resta quella di reinventare la realtà. Tutto questo e molto altro è L’Agnese va a morire, che la Viganò pubblicò nel 1949. È un racconto epico non meno che etico. È rimasto il culmine della sua creatività, forse perché irripetibile era l’esperienza che lo ha ispirato.
La storia si svolge nelle valli di Comacchio (mai nominate, ben riconoscibili) tra l’8 settembre del 1943 e la primavera del 1945. La narrazione di Renata Viganò è sommamente antiretorica. Non ci risparmia nulla: le brutalità della guerra partigiana, la disumanità dell’invasore sfogata soprattutto su civili inermi.
L’Agnese resta “l’Agnese” per tutto il testo, col suo articolo che diventa parte integrante del nome. Sembra una creatura tratteggiata dalla penna di uno dei grandi scrittori naturalisti francesi, Flaubert, Maupassant o Zola. Di più: se quei personaggi sono indimenticabili perché frutto di grandi ispirazioni, l’Agnese giganteggia ulteriormente perché è il risultato, oltre che di una maestria narrativa, di una profonda passione civile, temprata nell’azione diretta di una donna della Resistenza.
L’Agnese è grassa ma forte, energica come un animale da soma, anche se i suoi cinquant’anni di allora non erano quelli di oggi: per una contadina erano il limitare della vecchiaia. L’Agnese, scrive la sua autrice, ha un cervello “sveglio ma elementare” che “non poteva seguire troppe cose in una volta”. Ha il fatalismo della gente di campagna, fiuta infallibilmente l’arrivo delle disgrazie, inevitabile punteggiatura di quel genere di esistenza.
Ha sposato Ottavi Paolo detto Palita, tisico e inabile al lavoro, perciò deve lavorare per due. Le va bene così. Quando glielo portano via, denunciato come comunista dai vicini di casa e preso dai tedeschi per essere deportato in Germania, l’Agnese non crede per un solo istante che tornerà. Sa già che quella prova è troppo grande per il suo fisico. Il suo è un dolore nudo, silenzioso, animale, simile a quello di un cane che si limita a intristirsi e a uggiolare per piangere il padrone perduto. Senza accorgersene, scivola dentro la Resistenza. Accetta gli incarichi che le assegnano i vecchi compagni del marito, consegna loro tutti i suoi risparmi di lavandaia. Che ne farà ormai? In campagna le vedove portano il nero a vita, il lutto è il segno che l’anima è morta anzitempo e che sopravvive solo il corpo.
«Se sono buona», dice modestamente ogni volta che le assegnano un incarico, sempre roba pericolosa, da farla fucilare seduta stante se i tedeschi la fermano. Sa che in guerra i tempi fortunati sono brevi, presto ricominciano i guai. Non lo dice, lo tiene per sé. Diventa da subito “mamma Agnese” per tutti, compagni giovani e anziani. Se ha paura, non è mai per sé, visto che si sente vecchia, ma per quei ragazzi che rischiano la pelle perché hanno il fegato di far seguire le azioni ai pensieri.
L’Agnese procede nella vita come su un binario, quello della sua coscienza abitata da pochissimi valori, due o tre, su cui non è consentito sgarrare. Non cerca scorciatoie, non scappa davanti al pericolo. Questa dirittura non è sintomo di stupidità o incoscienza, è qualcosa che lei non può a nessun costo negoziare con la propria anima. Con la sua presenza massiccia, nel corpo e ancor più nella tetragona fedeltà alla causa, che pure ha sposato da così poco tempo, l’Agnese occupa tutto lo spazio narrativo, anche quando non si vede e non si sente, quando è in cucina a lavare i piatti per i compagni o a rammendare le loro calze bucate. Eppure il comandante della brigata partigiana ha compreso bene quali sono le sue qualità umane e morali, visto che le affida l’organizzazione della “caserma”: lei, sola donna in mezzo a tanti uomini. In quell’ambiente modellato sul cosiddetto sesso forte, a fare insieme da amuleto, da totem e da fortezza è una donna di mezza età, malata di cuore e senza istruzione.
L’Agnese non rivendica nessuna qualità, si limita a esercitarle. Non ne ha piena consapevolezza, le agisce come un animale si farebbe guidare dai propri istinti. Eppure tutti gliele riconoscono, tutti si appoggiano a lei come a un solido pilastro in un mondo precario, fatto di rifugi provvisori, di capanne tirate su con canne e destinate a bruciare in capo a qualche settimana. Chioccia di tanti partigiani, salvatrice di molti di essi, non salverà se stessa, come ci anticipa il titolo del romanzo. In una frase detta al compagno Clinto c’è il suo testamento morale e spirituale: «Noi non finiamo. Siamo troppi. Più ne muore e più ne viene. Più ne muore e più ci si fa coraggio. Invece i tedeschi e i fascisti, quelli che muoiono si portano via anche i vivi».
La Viganò ci mostra la guerra per ciò che è: spartiacque tra anime pulite e anime nere, tra gente perbene e delatori, tra coraggiosi e codardi o, per usare un’antinomia cara a Luis Sepúlveda, tra “eroi e carogne”. La spietata legge della guerra esige la sua quota di imbarbarimento anche dai giusti. Quando ti hanno ucciso sotto gli occhi il fratello, o la madre, o il figlio, si fatica ad avere pietà dell’uomo che una lurida faccenda ti ha opposto come nemico, che forse non ha le mani sporche di sangue, oppure è proprio lui, il loro assassino.
Il personaggio dell’Agnese, come Renata Viganò spiegò in un articolo su L’Unità, è ispirato a una donna realmente esistita, compagna di lotta partigiana con lei. È anche, in un certo senso, il suo “doppio” sfortunato. Lei borghese e istruita, il suo personaggio ignorante e semianalfabeta. Lei sopravvissuta e l’altra no. Entrambe staffette partigiane, entrambe operanti in quelle valli di Comacchio dove le canne «non fanno verde, non fanno ombra, ma nascondono».
Il lessico della scrittrice bolognese è neutro, né alto né basso, asciutto, descrittivo quanto serve, lontano dalla scelta colta di regressione linguistica di un Pavese o di un Fenoglio. Eppure il suo passato di poetessa “convenzionale” emerge qua e là in qualche riflessione, o nel modo di rendere questo paesaggio ingrato, fatto di paludi, di canneti, di zanzare, di sole a picco. Percepiamo la lucidità non ideologica di una donna di origini borghesi, che fin da bambina si era dedicata alla scrittura senza una precisa coscienza politica, che ha aperto d’un tratto gli occhi e finalmente ha visto come stavano le cose. E ha visto che se i tedeschi sono belve, i fascisti e gli altri collaborazionisti che li aiutano a braccare e uccidere loro compatrioti sono peggiori, nella scala morale occupano l’ultimo gradino.