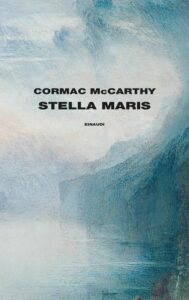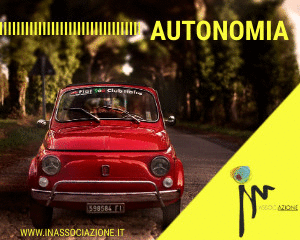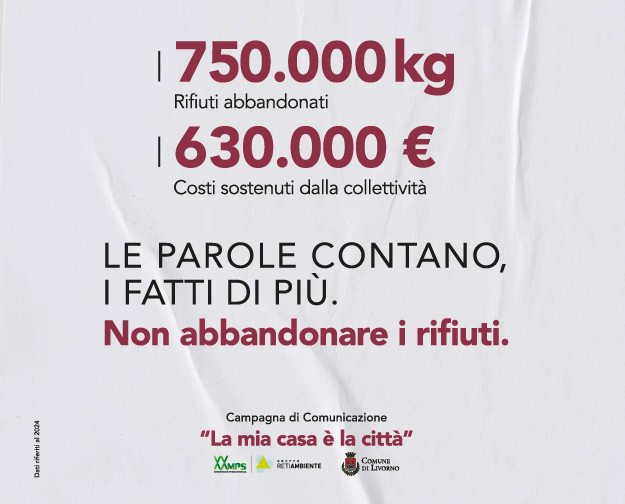Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Stella Maris” di Cormac McCarthy
Livorno 2 ottobre 2025 Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Stella Maris” di Cormac McCarthy
“Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
Rubrica di recensioni, a cura dello scrittore e traduttore Maurizio Grasso.
Non sono sempre necessariamente recensioni di libri appena usciti, ma di “buoni libri”.
Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Stella Maris” di Cormac McCarthy
Stella Maris è l’ultimo libro pubblicato da un quasi novantenne Cormac McCarthy. Sarebbe morto di lì a pochi mesi, il 13 giugno del 2023. Testo teatrale? Delirio cerebrale? Dialogo filosofico su noumeno e fenomeno? Un po’ di tutto questo e, nel contempo, qualcosa diverso e inclassificabile.
Stella Maris è il nome di «una struttura e hospice non confessionale per la cura di pazienti psichiatrici». Alicia Western, «ebrea caucasica di vent’anni, di bell’aspetto, forse anoressica», vi si fa ricoverare spontaneamente nel 1972. Alicia è un enfant prodige della matematica, laureatasi a soli sedici anni all’Università di Chicago, dottoranda nel medesimo ateneo.
Il testo di McCarthy, a parte una paginetta introduttiva a mo’ di didascalia, è fondato sulle sedute tra Alicia e il dottor Michael Cohen, lo psichiatra che l’ha in cura allo Stella Maris.
Dunque la sua è una trama dialogica, però non c’è nulla di teatrale, perché non c’è azione. I suoi due soli personaggi potrebbero non avere volto e restare al buio dietro un immaginario sipario.
Come è ovvio, c’è un’intenzionale struttura di domande da parte del medico. Tuttavia, esse si infrangono spesso su una diga di controdomande. Allora i ruoli si invertono. Il dialogo ora dà la stura alla memoria, ora vita a una nuvola di pura concettosità, a un tessuto metaforico-allegorico fatto di tali sottigliezze da dare l’impressione che il discorso di Alicia sconfini nella metafisica. Al contrario, si resta sempre ancorati all’immanente, a quella realtà ancora largamente inesplorata che è il cervello umano e il suo funzionamento.
Alicia fa al medico descrizioni fisiche minuziose, quasi fotografiche dei suoi fantasmatici “visitatori”, l’elemento chiave della diagnosi di schizofrenia. Su di essi lei ha una teoria, come potrebbe averla sulla meccanica dei quanti. La sua tendenza a razionalizzare si spinge fino al mondo irreale generato dalla propria fantasia.
Quando Cohen le fa notare che la Torazina, per quanto risulta dalla cartella clinica, ha fatto sparire le sue allucinazioni, lei risponde che certe molecole hanno il potere di alterare la realtà, rimuovendo alcuni suoi aspetti. Con ciò rivendica le proprie allucinazioni come parte non mutilabile della sua essenza.
Il medico immaginava di doversi misurare con una paziente psichiatrica, ma deve ricredersi. Ha di fronte un’intelligenza talmente superiore, raffinata e consapevole da mettere continuamente in crisi il discrimine che egli si è costruito nel tempo tra sanità di mente e follia o, volendo essere più precisi, tra genio e follia.
Negli ultimi anni della sua vita, Cormac McCarthy si era dedicato a esplorare la relazione tra inconscio e linguaggio al Santa Fe Institut. In particolare, sosteneva che l’inconscio preesistesse al linguaggio e ciò spiegherebbe perché buona parte delle immagini subcoscienti ci appaiano tuttora inintelleggibili. Col linguaggio «sono certamente andati persi talenti e abilità di ogni tipo, perlopiù comunicativi. La ricchezza dei sogni. Alla fine, questo strano nuovo codice deve aver in parte sostituito il mondo con quello che se ne può dire. La realtà con l’opinione», l’autore fa dire ad Alicia.
In questo libro, lo scrittore americano ha cercato di dimostrare quanto sia labile, sempre suscettibile di essere superata la tassonomia dei fenomeni mentali, disturbati o meno che siano. Il DSM-5 è un tentativo nobile ma costantemente imperfetto, nei suoi aggiornamenti, di classificare le cosiddette patologie della psiche in analogia con quanto fatto per quelle del soma. «La malattia mentale si distingue dalla malattia fisica in quanto a causare la malattia mentale è sempre e soltanto l’informazione», sostiene la sorprendente, oracolare Alicia.
Cohen si accorge che, più spesso di quanto potesse immaginare, il suo linguaggio è impreciso e, quando lo è, Alicia lo corregge sempre, lo perfeziona, dando in qualche modo ragione alla sua teoria dell’informazione come eziogenesi del disturbo psichico. Del resto, le idee suicidarie avute in passato non lasciano dubbi che una qualche forma di disagio Alicia la conosca e che ne abbia consapevolezza.
Alla lunga, emerge un sentimento inconfessabile, e il fatto che la ragazza riesca a tirarlo fuori dopo molte reticenze dice, o che la terapia di Cohen sta facendo breccia, o che la paziente cercava qualcuno “alla sua altezza” con cui confessarsi, pur senza la speranza di essere veramente compresa. «Lei non può vedere il mondo come lo vedo io. Non può vedere con questi occhi», dice Alicia al terapeuta.
La tesi dell’autore è che l’intelletto umano, laddove è particolarmente dotato, soprattutto per le scienze astratte come la matematica, può sconfinare in forme di visionarietà che ignoranza e pregiudizio classificano come espressioni di squilibrio mentale. Non è una tesi originale, ma è la tesi di uno scrittore. Nessuno darebbe del matto a un romanziere quando dice di essere stato abitato e tormentato dai propri personaggi finché non li ha messi in un libro, come Amos Oz scrisse della sua protagonista Hannah nella prefazione a Michael mio. Perché farlo con uno scienziato? Il libro di Sylvia Nasar sul grande matematico statunitense John Forbes Nash (da cui fu tratto il celebre film di Ron Howard interpretato da Russell Crowe) indagava in quella direzione, sebbene limitatamente a un singolo cervello.
Qual è il confine tra ispirazione, visione e allucinazione?
Qualcuno l’ha stabilito, l’ha indagato? Di sicuro Albert Einstein è stato visionario nell’immaginare la sua teoria fisica del mondo e le sue deduzioni, perché tutto ciò che ha teorizzato era controintuitivo. Non poteva essere basato sulla mera osservazione, bensì su un’immaginazione induttiva di portata mai prima conosciuta. Di sicuro non ci ha raccontato se queste sue “visioni” erano, e quanto, sinestetiche. Quand’anche abbia avuto di tali manifestazioni, le avrà classificate nel suo intimo come effetti collaterali dello studio stressato ben oltre l’involucro di apparenze della realtà fisica che protegge il mistero delle sue leggi.
Gli è stata attribuita una sindrome (quella di Asperger) tanto postuma quanto retrospettiva, dal momento che, quando lo scienziato tedesco morì, questa neurodiversità non era stata ancora coniata e definita. Ancora oggi l’Asperger è talmente “inclusivo” in termini sintomatici da comprendere tanto il ragazzo scarsamente verbale che si dondola continuamente senza accorgersene quanto un marpione come Elon Musk.
Ebbene, la giovanissima matematica Alicia Western entra nello Stella Maris con una diagnosi simile a quella appioppata al matematico Nash: «Schizofrenia paranoide con presenze ricorrenti di allucinazioni visive e uditive». Dalla prima pubertà vede figure, le ascolta, dà loro dei nomi.
Possiamo considerare Stella Maris, insieme al romanzo “gemello” Il passeggero, il testamento letterario di Cormac McCarthy? Penso piuttosto che sia stato solo il suo ultimo libro e, nel momento in cui lo scriveva, come accade a tutti gli autori, per lui il più importante. McCarthy resta in fondo uno scrittore epico, non solo perché si rivolge a un passato spesso abbastanza lontano, come in Meridiano di sangue o nella Trilogia della frontiera. Qui risale indietro di mezzo secolo esatto. Che cosa cercava nel passato? Credo cercasse l’eterno nell’uomo, ossia anche il suo presente e il suo futuro.