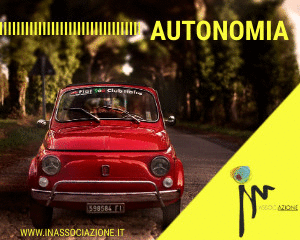Recensioni – “Patria” di Fernando Aramburu
Patria è una vicenda aspra e nobile, profondamente umana e al tempo stesso brutale
Livorno 03 novembre 2022 – “Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”
Rubrica di recensioni, a cura dello scrittore e traduttore Maurizio Grasso.
Non sono sempre necessariamente recensioni di libri appena usciti, ma di “buoni libri”.
Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Patria” di Fernando Aramburu
Due donne anziane: Bittori e Miren. I loro mariti, i figli. Due donne dure, ostinate, scolpite nella pietra della loro terra, Euskadi.
Bittori parla davanti alla tomba del marito, detto “il Txato”, piccolo imprenditore assassinato dall’ETA vent’anni prima perché si era rifiutato di pagare “l’imposta rivoluzionaria”. L’agguato era stato il tragico corollario di una campagna diffamatoria montata per intimorirlo e mettergli contro gli abitanti del paese. Bittori racconta di tutto al defunto marito; anche e soprattutto post mortem, è rimasto il suo confidente. Per lei è di grande conforto che il Txato sia diventato un ascoltatore così formidabile come mai era stato da vivo. Sua figlia Nerea cerca da anni di salvare il proprio matrimonio. Il figlio medico, Xabier, la preoccupa perché a quarantotto anni non ha una compagna.
Miren va in chiesa ogni domenica portandosi in carrozzina Arantxa, la figlia paralizzata da un ictus. Va a parlare con la statua di sant’Ignazio di Loyola, il più illustre dei Baschi. Al santo chiede di punire il genero che ha mollato a lei quel fardello umano; di restituirle i due nipoti, che vivono col padre e raramente vengono a trovare la mamma; soprattutto, di far uscire di galera il figlio terrorista Joxe Mari con un’amnistia. L’esercito rivoluzionario ha infatti dichiarato la fine della lotta armata.
Bittori e Miren sono dello stesso paese, Guipúzcoa, vicino San Sebastian. Erano amiche, “migliori amiche”. Si erano sposate quasi insieme e invitate ai rispettivi matrimoni. I loro mariti, Joxian e Txato, erano amici, anche loro migliori amici. Il primo senza iniziativa e carattere, operaio in una fonderia, il secondo padroncino di camion e col pallino degli affari. Generoso. Quante volte il Txato ha aiutato sotto banco Joxian e i suoi. Ha comprato la prima bicicletta al futuro etarra Joxe Mari, e come è stato ripagato?
Da un giorno all’altro, tra le due famiglie cala una cortina di ferro. Le prime scritte di accusa al Txato capitalista e oppressore sono la scintilla che appicca il fuoco a una catasta di invidie paesane. «Pensano che tutto quello che ho io l’abbia rubato». Miren, con un figlio latitante, prende posizione “contro” e suo marito Joxian, suo malgrado, la imita. Questa fatwa basca manda in frantumi, per i due nuclei familiari, un passato comune fatto di frequentazione e di affetto; lo trasforma in un’intricata matassa di odi incrociati. Perché a Guipúzcoa non è consentito essere neutrali. O si è a favore dell’ETA, oppure si è suoi nemici, cioè nemici del popolo basco.
Questa amicizia tra le due famiglie, tra i genitori, tra i figli cresciuti insieme, Fernando Aramburu ce la restituisce per l’appunto in frantumi. Centoventicinque brevi capitoli prelevano materiale (con apparente disordine) direttamente dalla memoria dei nove protagonisti. In realtà è un cerchio che insensibilmente si stringe. Nel mezzo di un mosaico che ricompone il passato si insinua sempre più, anch’esso frammentario, il presente di queste persone. Un tempo erano così unite e ora sono centrifugate come schegge di un big bang. Anche le distanze intra-familiari si sono espanse. Ognuno si è vissuto questo terremoto secondo il proprio carattere, in solitudine. Più il tempo passa, più è difficile ricevere e dare ascolto, ricostruire comprensione reciproca e armonia.
Protagonista di Patria di Fernando Aramburu è l’identità Euskal Herria, il popolo basco che parla euskera. È la lingua viva più antica d’Europa: un fossile glottologico le cui origini si perdono letteralmente nella notte del Sapiens. Questo idioma misterioso pervade i dialoghi in castigliano, un termine qui uno là. Li fodera in una corteccia di colloquialità domestica e di aspra ironia, come a ribadire la propria insostituibilità espressiva.
Ma l’identità basca è tutt’altro che un monolite. La “Patria” cui allude Aramburu è attraversata da una linea di faglia rosso scarlatto. L’ETA ha fatto scorrere anche sangue basco, e molto, non solo quello della Guardia Civil o dei politici centralisti. Che sia fondata o calunniosa, una scritta offensiva sui muri basta perché un intero villaggio si coalizzi contro chi ne è colpito. Fino a ieri era “uno di loro”: oggi è un avversario.
Ma ora che la lotta armata è un capitolo ufficialmente chiuso, potrebbe, dovrebbe essere il momento della pacificazione. Non è facile. Parenti delle vittime e dei carnefici si leccano le rispettive ferite su sponde opposte. Da una parte il comitato per l’amnistia, dall’altra quello per gli orfani e le vedove. Lo scrittore basco ci mostra quanto sia più facile scendere la china del rancore piuttosto che tirare il freno. Un’incontrollabile reticenza impedisce di fermarsi a riflettere, di guardare in trasparenza parole come pace, concordia, o addirittura perdono. Chiedersi se si possano fare proprie, da una parte come dall’altra. Le vittime che hanno perso un padre o un marito senza aver mai ricevuto scuse. Chi invece piange un figlio dell’ETA che non uscirà più di prigione o è morto in circostanze mai chiarite.
Quanto resta delle famiglie di Bittori e Miren si misura ogni giorno con simili sentimenti e scrupoli. Non può evitarlo, la Storia ha voltato perentoriamente pagina e nessuno di loro, neanche volendo, può più vivere in quella precedente. Tentativi di riavvicinamento avvengono tra i figli, più giovani e flessibili. L’ostacolo duro da rimuovere sono le madri, concentrate testardamente sul proprio lutto. Il dolore dell’una non ha intenzione di venire a patti con quello dell’altra, non si sente inferiore. Ma il processo non si può fermare e, lavorando ai fianchi la più tenace delle resistenze, alla fine la vincerà. Avverrà nell’ultimo capitolo, il centoventicinquesimo. Un alternarsi in crescendo, cinematografico, di inquadrature tra Bittori e Miren, che finalmente si fronteggiano in un loro privato “O.K. Corral”.
Da basco, Aramburu fa il censimento della devastazione materiale e psicologica che decenni di lotta armata hanno lasciato in Euskadi. È comprensivo verso chi ci ha creduto, non verso chi ha ammazzato, Né verso chi ha torturato in galera i militanti catturati. È stato anche lui un adolescente basco e come tale esposto alle sirene di quel progetto di Patria. Tuttavia, il tempo ne ha smascherato ai suoi occhi l’insensatezza; quale autorità può arrogarsi il diritto di decidere a colpi di pistola chi appartenga e chi no a quella Patria? È vero, la violenza come strumento di emancipazione ha perso. Non per questo bisogna scaraventare nel rimosso gli sconfitti. Non vi sarà vera pace senza dare loro la possibilità di parlare, di ponderare a freddo e, possibilmente, di redimersi.
Merito fondamentale di questo libro è di aver desecretato a trecentosessanta gradi gli anni di piombo dell’ETA. Osservati di riflesso nei comportamenti degli individui, dei gruppi familiari, i fatti confessano anche ciò che era rimasto “tra le righe” dei documenti. Diventano più trasparenti, intellegibili. Con la sua energia espressiva, con le sue intuizioni penetranti un romanzo ha più frecce nella faretra rispetto a un saggio. Quest’ultimo, incardinato sui binari dell’analisi storica obiettiva, risulterà sempre più freddo. E l’interpretazione dello storico, conseguentemente, manterrà un elemento percettibile di scollamento, di arbitrarietà.
Patria è una vicenda aspra e nobile, profondamente umana e al tempo stesso brutale. Non è soltanto una pagina di storia trasfigurata dalla creatività di un narratore, è soprattutto un’opera artistica riuscita. Che abbia anche vinto dei premi letterari internazionali per me conta zero. Il miglior complimento che mi sento di fare a un romanzo è di avermi coinvolto perché mi è apparso “vero”. Patria di Fernando Aramburu è esattamente questo.